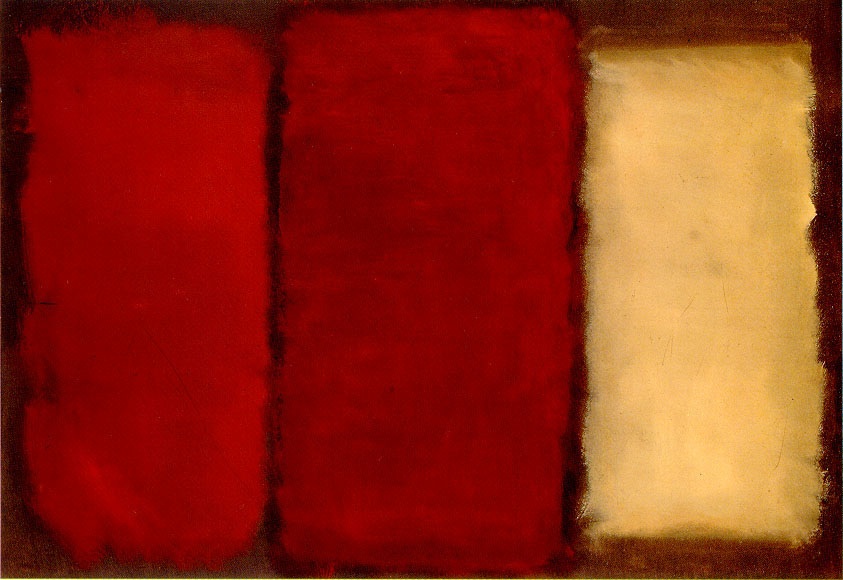La ola è una tra le più plateali – e attuali – forme di contagio emotivo, un cambiamento emotivo indotto dall’assunzione “mimetica” dell’espressione, dell’atteggiamento e/o comportamento altrui. La ola calcistica è infantilmente giuliva, forse divertente ma nessuno di noi si immaginerebbe di capire il o sentirsi empaticamente capito meglio dal vicino di stadio per il solo fatto di averla con lui condivisa. L’empatia è cosa ben diversa dal contagio emotivo. Vi sono inoltre molte forme di contagio emotivo, alcune delle quali subdole, insidiose e, nella loro assenza di consapevolezza, pericolose, come le travolgenti correnti aggressive del film l’onda e le tante altre reali tragiche dinamiche ideologiche di massa, fondate appunto sull’omologazione collettiva.
Il contagio emotivo è anche parte integrante del fenomeno della viralità online. Un ottimo esempio è costituito dai più di 36.000 like ottenuti in questi giorni dal profilo di un criminale sul sito della polizia californiana. La trasmissione di emozioni, positive e negative, tramite social media è stata ora per la prima volta anche confermata da un convincente studio sperimentale pubblicato su PNAS. Una ricerca condotta sulle interazioni Facebook di quasi 700.000 utenti dimostra che “gli stati emozionali possono essere trasmessi agli altri tramite contagio emotivo portando le persone a provare le stesse emozioni senza averne consapevolezza”. L’esperimento dimostra inoltre che “il contagio emotivo avviene senza diretta interazione tra le persone (è sufficiente l’espressione di un’emozione ad un amico) e in completa assenza di stimoli non verbali”.
Luca Chittaro, uno degli organizzatori della conferenza internazionale sulle tecnologie persuasive tenutasi quest’anno per la prima volta in Italia, va oltre e sulle colonne di Nòva ha illustrato lo stato dell’arte di tali tecnologie. Tra i tanti filoni sviluppati e da lui esposti vi è quello della prevenzione delle catastrofi sociali (del tipo ad es. della love parade di Duisburg) attraverso un’orchestrazione integrata dei social media da parte degli enti organizzatori che in tali casi devono agire all’unisono (è anche solo pensabile in Italia?).
I social media possono dunque venir impiegati è proprio il caso di dire onlife per evitare/ridurre l’insorgenza di una pericolosa forma di contagio emotivo, il panico di massa, e per indurre invece altri più rassicuranti stati d’animo. Inoltre in tali circostanze il micro-blogging può offrire, bottom – up, dai singoli alle autorità, preziose informazioni per conoscere e gestire meglio la situazione, nel senso che – scrive Chittaro – “gli utenti Twitter possono svolgere una funzione simile a quella che nell’epoca pre-social network era tipica dei radioamatori nei disastri, con il vantaggio di essere molti di più “. Per filtrare, ordinare e rendere utilizzabile l’enorme massa di messaggi/Tweet generati dai singoli in un’emergenza c’è però bisogno – aggiunge Chittaro di “strumenti semi-automatici” di comprensione e interpretazione del testo.
I principi di funzionamento di tali sistemi di tecnologia semantica applicati a Internet e ai social media li spiega sempre qui su un blog di Nóva in una sorta di giallo tecnologico a puntate Marco Varone . Cristina Cenci analizza invece “le conversazioni online per capire vissuti, bisogni, rappresentazioni sociali associate alla salute e alla malattia” e ci racconta di come la “parola collettiva” dei social media possa curare e di come ad esempio “il selfie per il cancro” sia diventato “un canto taumaturgico online, [che] esorcizza la parola che più di altre nel contemporaneo incarna il fantasma della morte”. Altri studi dimostrano poi l’utilità psicologica e psicoterapeutica dei social media in caso di catastrofe ambientale, quali il terremoto di Haiti, per favorire il contatto tra i sopravvissuti ed incrementarne la resilienza.
Di fronte all’affascinante interconnessione di tanti saperi, alla potenziale collaborazione di tanti esperti, alle incredibili possibilità offerta dalla tecnologia, provo una contagiosa meraviglia che mi spinge a ripensare vecchie tecniche di terapia in forme nuove. Mi chiedo e chiedo se non sia possibile immaginare tutte le interazioni di un hasthag come un’ (enorme) dinamica di gruppo animata da fattori consci e soprattutto inconsci, passibili di analisi ed interpretazione. Ho cercato di descrivere e analizzare alcune di queste dinamiche in occasione di due eventi tragici (il terremoto dell’Emilia, e la morte per suicidio di una ragazza quattordicenne) e di ripercorrere il processo di gruppo sviluppatosi nel corso dell’esperimento #tmente I miei sono tentativi parziali, artigianali e manchevoli ma l’introduzione di tecnologie semantiche, la valutazione di metriche, ed altri parametri rivelatisi magari importanti per le digital humanities potrebbero offrire nuovi strumenti per capire e gestire complessi fenomeni emotivi di massa sulla base anche dei concetti della psicologia del profondo.
Decisivo potrebbe essere al riguardo l’obiettivo dell’empatia, quella che non c’è nella ola e nemmeno nei fenomeni solamente virali ma che si può realizzare nelle interazioni sociali off- e online e può essere sollecitata e stimolata dalle situazioni ma anche da tecniche psicoterapeutiche, come il gruppo Balint o meglio da una rivisitazione dello stesso. Sarebbe possibile immaginare allora, non solo per gruppi di persone affette da disturbi fisici o psichici, ma anche per tutti quelli che lo desiderino, di fronte a situazioni di pericolo ambientale/sociale e anche a fatti di cronaca emotivamente fin troppo coinvolgenti (es #MottaVisconti) gruppi Balint via Twitter? Per superare proprio il puro e semplice contagio emotivo della paura o della rabbia, la (pseudo)catarsi dei Tweet scagliati come pietre contro il presunto colpevole e/o deposti come fiori (di plastica) sul luogo del massacro delle vittime. Certo anche i sentimenti più estremi, le fantasie più atroci e i pensieri più azzardati devono trovare posto in ciascuno di noi e nel gruppo se davvero vogliamo elaborare difficili vissuti emozionali. Ma vanno inseriti in un setting definito, che contenga e sostenga, che renda possibile il confronto con l’altro da e di noi, che susciti nuove domande e nuove prospettive, che ci dia la possibilità di superare i facili dualismi emotivi e di pensiero e ci inviti invece a fare i conti con il guazzabuglio del nostro cuore. La più bella e completa definizione di empatia mi sembra quella di Kutter, che la descrive come la triplice capacità di identificarci con l’altro, ma anche di ritirarci, rispettivamente di distanziarcene e di oscillare tra queste due funzioni parziali. Un’empatia dunque non già bella e scodellata sulla tavola imbandita dai nostri neuroni specchio ma intesa come risultato di un (dispendioso) processo che avviato dai neuroni specchio deve farsi faticosamente strada fino alla coscienza e che va pazientemente esercitata, come e più dei muscoli. È dimostrato che il gruppo Balint aiuta a migliorare le capacità empatiche dei partecipanti. Un training d’empatia onlife?
Foto tratta da www.etc.cmu.edu Rothko