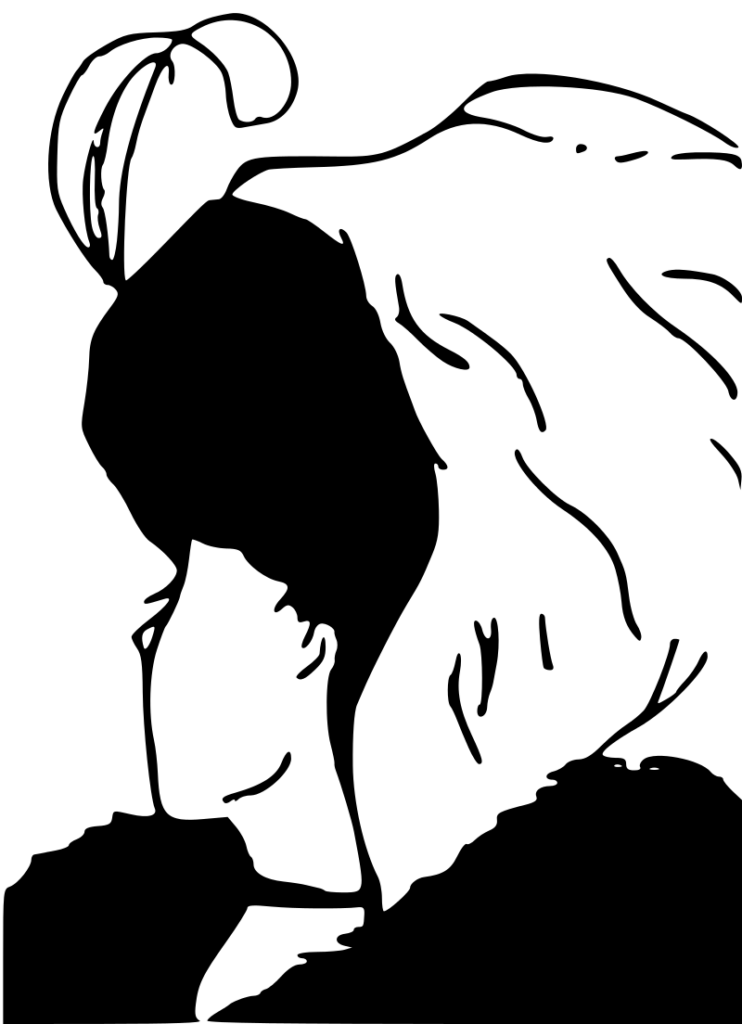“Mi sentivo bloccata, paralizzata dallo sguardo fisso di quel paziente schizofrenico così insistente e invadente al punto da dover interrompere il colloquio” mi racconta una collega nel corso di una supervisione. Nel successivo svolgersi della conversazione diviene chiaro che la paura della collega ha a che fare non solo con la pregressa aggressività del paziente in questione ma anche con le esperienze e i vissuti di abbandono e impotenza sperimentati dalla stessa collega nel proprio passato. Con un po’ di esperienza, è facile individuare le difficoltà, i limiti, gli errori degli altri. Ma quando porto io in supervisione/intervisione un mio caso non è tutto così facile. Sono io che non riesco a vedere dove sta il problema che impedisce un’evoluzione del decorso o comunque un passo avanti. Eppure il problema mi sta davanti al naso, agli occhi. Perché li apro solo dopo?
Me lo domandavo leggendo un bellissimo articolo di Elizabeth Kolbert recentemente apparso sul New Yorker. La giornalista, vincitrice di un premio Pulitzer, affronta proprio il tema della nostra difficoltà ad imparare dai fatti prendendo le doverose distanze dalle nostre scorrette e pregiudizievoli opinioni. Per farlo illustra il risultato di molte ricerche psicologiche e riassume brillantemente le conclusioni di tre libri di recente pubblicazione su questo ed analoghi argomenti.
Il primo è “The Enigma of Reason” (Harvard), frutto del lavoro comune di due cognitivisti Hugo Mercier and Dan Sperber.La tesi, semplificata, è che il vantaggio principale di noi umani nei confronti delle altri specie sia la cooperazione, capacità tutt’altro che facile da instaurare e ancor più da mantenere. La ragione, di cui tanto andiamo fieri, non si sarebbe sviluppata con lo scopo di risolvere problemi logici, astratti, di trarre conclusioni originali da nuovi dati ma piuttosto con l’obiettivo di risolvere i problemi posti dalla vita di cooperazione e collaborazione in gruppo.
“Reason is an adaptation to the hypersocial niche humans have evolved for themselves,” scrivono Mercier and Sperber. I “confirmation bias” sarebbero dunque secondo gli autori non degli errori incidentali ma l’ espressione della nostra tendenza evoluzionistica a confermare le nostre opinioni e a rigettare invece quelle che potrebbero metterle in discussione, mettendoci in una posizione di svantaggio nel gruppo. Proprio per questo gli autori preferiscono brillantemente parlare di “myside bias”. Non siamo infatti affatto creduloni in generale, limiti e difetti altrui li individuiamo rapidamente, siamo però selettivamente ciechi nei confronti dei nostri.
Altri due cognitivisti Steven Sloman e Philip Fernbach autori di “The Knowledge Illusion: Why We Never Think Alone” individuano nella socialità la caratteristica peculiare che fa funzionare (male) la nostra specie. Siamo a loro avviso così “sociali” che anche i nostri pensieri sono difficilmente separabili da quelli dei nostri simili. Senza rendercene conto ci basiamo su conoscenze altrui che crediamo (di aver fatto) nostre. Questo interscambio di pensieri quasi senza soluzione di continuità sta certo alla base del progresso scientifico, consentendo ricombinazioni potenzialmente infinite. Quando però ci viene banalmente chiesto di spiegare in dettaglio il funzionamento di una toilette dobbiamo riconoscere che la nostra profondità di spiegazione è solo apparente “illusion of explanatory depth”. Passi per la toilette. Il problema è che ciò vale a maggior ragione per argomenti molto più complessi, quali quelli politici. Non sapendone niente, pensiamo di capirli e risolverli facilmente. E tanto minore è la conoscenza, tanto maggiore l’intensità della nostra (auto)convinzione.
Lo dimostra un semplice ma brillante esperimento. Poco dopo l’annessione della Crimea da parte della Russia è stato chiesto a un campione di cittadini americani di esprimere il loro parere sulla reazione che gli USA avrebbero dovuto tenere e contemporaneamente di indicare l’Ucraina su una carta geografica. Peggiori erano le conoscenze geografiche, maggiore era la loro tendenza a favore di un intervento militare. Gli autori concludono sobriamente: “As a rule, strong feelings about issues do not emerge from deep understanding”. Naturalmente lo sapevamo già, dalla frequentazione pur non assidua del bar dell’angolo, dove i più complessi problemi mondiali trovano le più semplici ed altrettanto appassionate soluzioni. Ora il metodo sembra così di successo da essere approdato addirittura anche alla Casa Bianca.
Infine in “Denying to the Grave: Why We Ignore the Facts That Will Save Us” (Oxford), uno psichiatra, Jack Gorman, e una specialista di salute pubblica, sua figlia, Sara Gorman, dimostrano che nel riconfermare le nostre pur scorrette opinioni proviamo un piacere non diverso da quelli indotto dai più tradizionali istinti e pure mediato dalla liberazione di dopamina. Come già visto, confutare le false credenze non serve a nulla. Fare appello alle emozioni sarebbe più efficace ma antiscientifico
“Appealing to their emotions may work better, but doing so is obviously antithetical to the goal of promoting sound science.”
Pur senza averne titolo, riconfermando dunque i miei pregiudizi 😉 , mi permetto qui di dissentire o meglio di precisare. Le emozioni sono molto potenti e fanno per questo paura, soprattutto a noi maschi, confessiamolo. Abbiamo la sensazione che distorcano la lineare e pura traiettoria del pensiero razionale come la forza di gravità fa con la luce. Eppure i nostri pensieri originano dalle emozioni e le emozioni continuano a fornirci informazioni decisive per capire noi stessi e gli altri e cosa sta capitando in noi e in loro. La mia già citata collega ha potuto rendersi conto della propria macchia cieca e io nella mia supervisione delle mie, proprio perché nella supervisione le emozioni non vengono evitate ma trovano invece posto . Vengono accolte, ascoltate, comprese e nei limiti del possibile obiettivamente interpretate come preziosi segnali delle reazioni psicologiche in corso. Ciò è possibile grazie alla condizione di astinenza, individuata e suggerita da Freud per l’analisi e adottata in tutte le terapie e supervisioni ad indirizzo analitico. Non si tratta di una sterile neutralità, né – come pure lui inizialmente suggeriva – di un semplice specchio offerto dal terapeuta al paziente o dal supervisore al supervisionando. È piuttosto un’atmosfera empatica che consente libertà di pensiero e di emozioni, all’interno della quale nasce e si sviluppa, senza moralismi, la riflessione su sé stessi. A far da guida sono proprio le stelle delle emozioni, prima vissute, poi consapevolmente percepite, espresse, discusse e analizzate criticamente. Proprio perché il processo non si svolge (dovrebbe svolgere) sotto la pressione della sfida, dell’intollerante lotta di potenza, del moralistico giudizio, le mybias possono essere superate e un nuovo sguardo può farsi strada. Prima su di me e poi sull’altro.
Consiglio musicale: Händel, Il trionfo del tempo e del disinganno, Lascia la spina, cogli la rosa