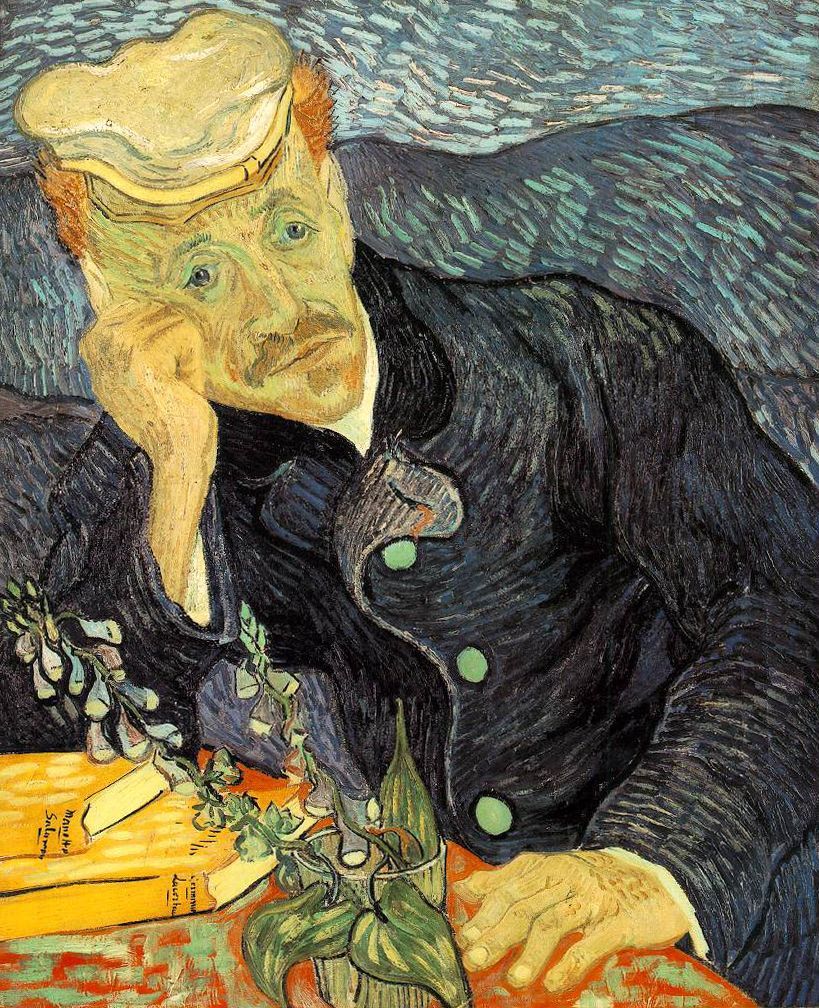“Mi lamento e piagnucolo come i miei pazienti” si rimproverava un* colleg* da me in terapia per “Burnout”. D’altro canto, convenivamo, a tutt’oggi non si sa di un gene o di una terapia che renda gli psichiatri meno lamentosi e antropologicamente meno vulnerabili dei loro pazienti. Il 38% degli psichiatri americani afferma di stare sperimentando un Burnout Si potrebbero consolare sapendo che i colleghi che lavorano nell’emergenza vanno incontro a Burnout nel 53% dei casi! O invidiare i dermatologi che sperimentano Burnout “solo” nel 37% dei casi. Di fronte però ad un Burnout che colpisce il 46% (secondo altre statistiche il 54%) di tutti i medici americani! questi confronti tra diverse categorie mediche, pur scientificamente interessanti per individuarne le cause, sono praticamente poco rilevanti. Si aggiunga l””epidemia di suicidi” tra giovani medici di cui riferiva recentemente il Guardian
Ma al di là del rischio per i medici, il dato di fatto è che ogni paziente ha circa un 50% di probabilità di imbattersi in un medico bruciato emozionalmente e dunque ridotto nelle sue capacità non solo empatiche ma anche di applicazione pratica delle sue competenze scientifiche. Il dato di per sé tragico rischia di diventare tragi-comico quando si vadano ad esaminare le presunte cause del burnout. Che per l’ambito psichiatrico sono state così elencate (da una seria rivista)
many bureaucratic tasks
Income not high enough
Spending too many hours at work
Inability to provide patients with the quality care that they need
Too many difficult patients
Increasing computerization of practice
Too many appointments in a day
Che sarebbe un po’ come dire che gli ingegneri soffrono di burnout perché devono fare troppi progetti prima di realizzare i loro ponti o perché le correnti a cui devono resistere i ponti stessi sono troppo difficili. Certo al Burnout di noi psichiatri possono contribuire cause specifiche come lo stigma, la possibile violenza dei pazienti, mettiamoci pure, con un certo spirito vittimistico, la scarsa reputazione in cui siamo tenuti dai colleghi delle altre discipline (?) ma dobbiamo pure riconoscere che quanto vale per tutti gli altri a proposito del Burnout vale anche per noi. E cioè che, come dimostra ad es. un importante studio svizzero, già citato, condotto in Joint Research dal Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Zurigo e dall’ETH ” i fattori predisponenti al Bornout sono assai poco legati al lavoro e molto più invece alla personalità dell’individuo, a tratti psicopatologici, ai disturbi psichici precedenti dello stesso e alla sua condizione relazionale” Quando sono ricorso all’aiuto di un* colleg* è stato certamente anche perché non sopportavo più ritmi e modalità di lavoro che io stesso avevo lasciato diventare ingestibili (quasi 50 ore di lavoro con i pazienti, senza contare quelle di supervisione, intervisione, amministrazione, gli imprevisti, le urgenze, i picchetti, le telefonate, e-mail, SMS, WhatsApp…) Ma quello era solo una parte del problema anzi più correttamente la conseguenza della mia incapacità a gestire i miei problemi, la scusa per non affrontarli. Il primo passo verso la risoluzione lo si fa proprio nel momento in cui si comincia a sottrarsi alla logica del lavoro, del dovere cieco e a prendersi tempo per affrontare i propri conflitti, che sono sempre più spiacevoli delle pure spiacevole condizioni di lavoro che li nascondono. Da lì si comincia a riconoscere che il problema non è il lavoro ma l’immagine di noi che lo specchio ci riflette. O meglio il divario tra l’immagine riflessa e l’immagine che noi vorremmo vedere, tra i desideri che nutriamo e di quelli che abbiamo la forza il coraggio di realizzare. Andare in terapia può essere allora per la/il terapeuta così come per qualsiasi altro/a un primo passo per prendersi cura di sé indipendentemente dal fatto che la terapia comporti rilassamento, Mindfulness, riflessione analitica, ferie, antidepressivi o quant’altro. “Quando prendo l’antidepressivo sto bene ma poi mi sento troppo simile ai miei pazienti – mi diceva un altr* colleg* in terapia – e allora lo smetto ma poi torno ad essere più irritabile”. Come se il ruolo di terapeuta ci trascinasse inevitabilmente in fantasie di onnipotenza (e dunque anche di responsabilità assoluta) che sono poi le stesse che ci conducono successivamente a sentirci dei salvatori falliti e a cadere nel Burnout. Abbiamo allora, almeno noi terapeuti, il coraggio di chiamarlo per quello che è, col suo vero nome: depressione, sia pure, generalmente, ma non sempre, di grado lieve. Se siamo noi i primi ad aver paura di usare per noi il nostro stesso linguaggio, i nostri codici (ICD10 o DSMV che siano) che usiamo ogni giorno per i pazienti, come possiamo credibilmente chiedere alla società di liberare le persone che soffrono di disturbi psichici dallo stigma? Ammettere le proprie debolezze, in un’epoca di narcisistica idolatria del successo, non è proprio facile ma certamente liberatorio, oltre che un passaggio obbligato per essere sé stessi.
Forse allora oltre alla supervisione, all’intervisione, all’aggiornamento, alle ferie, al relax, al wellness, al Tai Chi fa bene, o ancora meglio raccontare le proprie storie. O almeno leggere i racconti altrui. Come scrive in uno splendido post Storie di medici online Francesca Memini le storie servono
“a creare identità: a dire al mondo chi siamo, quali sono i nostri valori, come la vediamo noi dal nostro punto di vista, qual è la nostra interpretazione dei fatti. A rafforzare il legame sociale: creare identificazione, a rafforzare il legame sociale tra chi condivide quel racconto e quei valori.”
Anche i medici raccontano le loro storie personali “Blog divenuti autorevoli come www.kevinmd.com raccolgono voci di medici e di pazienti, ma online ci sono anche altre forme di narrazione, per esempio i fumetti ”
Queste narrazioni sono utili ai medici ma anche, continua Francesca Memini, alla medicina e ai pazienti:
“Per umanizzare la medicina bisogna umanizzare i medici, o meglio lasciar loro la possibilità di raccontarsi come esseri umani.” Solo così “il paziente è in grado di riconoscere al medico la sua umanità”
Le storie curano, diceva Hillman. Anche i fumetti. Forse anche gli psichiatri.